"Il più bello dei mondi è un mucchio di rifiuti gettato dal
caso"
(Teofrasto, metafisico, III sec a.)
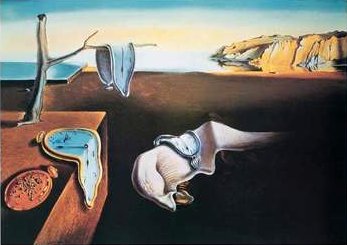
Abbiamo parlato di un crollo delle
certezze, carattere tipico delta scienza del '900. Abbiamo anche accennato
fin qui al fatto che le
radici di questa incertezza sono da ricercare nel disfacimento del modello di scienza
cartesiano, newtoniano e
galileiano. Ebbene questa crisi profonda dei fondamenti del discorso scientifico è stata
analizzata
con un'attenzione particolare a cominciare dalla seconda metà del nostro secolo, e la ricerca si è
centrata
attorno ad un concetto particolare, molto evocativo e
suggestivo, racchiuso in una parola,
complessità,
che ha ormai assunto connotati quasi magici.
Non bisogna però pensare a questo termine, né alla teoria che
simboleggia, come a qualcosa di assolutamente
nuovo e inedito nella
tradizione filosofica e scientifica. Come del resto qualsiasi attività umana, anche la scienza
deriva in parte la spinta al proprio procedere
dal bisogno di rispondere ad alcune esigenze, spesso angoscianti,
sorte
nel corso dell’esistenza di una collettività, fra le quali ovviamente quella di ricreare un modello
comprensibile, un'immagine coerente del mondo entro cui viviamo.
In questo senso la messa in campo del concetto di complessità ha
implicato il riproporsi di una vecchia domanda, ha significato rimettere in
discussione una tradizione scientifica che, per lo meno a partire da Newton
(ma si potrebbe andare più indietro
nel tempo) aveva dato per certi versi il posto centrale dell'uomo nell'universo creato e il ruolo della
scienza come sua attività conoscitiva superiore. Se oggi parliamo di
una
scienza della complessità questo non
deve comunque trarre in inganno: non significa rinnegare oltre tre secoli di
storia della conoscenza
umana, ma piuttosto fornire un’interpretazione adeguata al problema di cui ci stiamo
occupando
attraverso un nuovo concetto.
Il
problema è intanto quello di
capire la differenza non solo linguistica, ma anche fortemente epistemologica
che corre fra due termini
che sono solo apparentemente simili: complicato e complesso. Poniamoci alcune
questioni.
In primo luogo: parlando di un fenomeno la cui spiegazione ci obbliga a
mettere in gioco un numero considerevole di variabili, dipendenti o
indipendeni1 soprattutto per quanto riguarda la sua espressione in chiave simbolico-numerica (una formula) o
in chiave descrittiva (un teorema), cos'è che ci autorizza a considerarlo un "fenomeno
complesso"?
 E inoltre: la messa in evidenza, all'interno di questo fenomeno,
osservato nel suo sviluppo, di alcune congruenze e condizioni di ordine
ricorrenti deve farci pensare che vi è una semplicità della spiegazione sotto
un'apparente difficoltà
di lettura, che esiste una struttura nascosta?
E inoltre: la messa in evidenza, all'interno di questo fenomeno,
osservato nel suo sviluppo, di alcune congruenze e condizioni di ordine
ricorrenti deve farci pensare che vi è una semplicità della spiegazione sotto
un'apparente difficoltà
di lettura, che esiste una struttura nascosta?
Oggi la scienza ha compreso che nella conoscenza della realtà non si
tratta soltanto di raccogliere un numero
considerevole di dati relativi ad un
fenomeno, per meglio definirlo, e che non è il numero elevato di variabili in
gioco a stabilire
la presenza di una complessità, quanto piuttosto il loro essere visibilmente intrecciate in una
rete di
relazioni.
Ciò che fa davvero la differenza
tra due concetti di complesso
e complicato è la scoperta che tutti i fenomeni, soprattutto quelli legati al
mondo del vivente,
mostrano un'apparente mancanza di ordine nella propria evoluzione e a volte
nella stessa struttura,
caratteristiche che non permettono di ricostruire certe serie di eventi, come
quelle della biologia
contemporanea, se non come processi caotici. Il
contesto entro cui la scienza contemporanea parla di una scoperta della
complessità si individua così
nella scoperta del carattere imprevedibile di alcuni fenomeni, e nella comprensione del fatto che:
 Nella scienza non esistono oggetti semplici, cioè la ricostruzione di
un evento osservato sembra
rispondere a leggi
deterministiche ma va
ben oltre queste leggi;
Nella scienza non esistono oggetti semplici, cioè la ricostruzione di
un evento osservato sembra
rispondere a leggi
deterministiche ma va
ben oltre queste leggi;
 La previsione dello stato futuro di un sistema può sembrare
possibile, ma a costo di ridurre qualitativamente la portata di un fenomeno
studiato;
La previsione dello stato futuro di un sistema può sembrare
possibile, ma a costo di ridurre qualitativamente la portata di un fenomeno
studiato;
 Le qualità
riscontrate in un oggetto studiato non sono proprie di quell’oggetto, ma sono
la risposta della sua interazione con l'osservatore,
sono il suo "modo di vederle".
Le qualità
riscontrate in un oggetto studiato non sono proprie di quell’oggetto, ma sono
la risposta della sua interazione con l'osservatore,
sono il suo "modo di vederle".
Questo rappresenta il vero punto di partenza di ogni possibile
riflessione sul ruolo stesso della scienza, sulla sua ricerca di una coerente immagine
del mondo.
Il criterio che permette di differenziare
complicatezza e complessità
dovrebbe comunque scaturire anche
dall'evidenza del limite intrinseco
alle spiegazioni che la scienza "classica" ha dato dei fenomeni, quelle cioè che
puntano a semplificare, a
ridurre, a sminuire la portata di un fenomeno, ad ignorare le innumerevoli relazioni
possibili fra
fenomeni ed eventi diversi. Quindi, nel momento in cui si prende coscienza dell'esigenza di una
nuova
situazione teorica si dovrebbero, per cosi dire, ridisegnare anche gli strumenti e le procedure d'indagine
della scienza e il sistema delle pratiche sperimentali di ogni disciplina.
La
ricerca scientifica dei nostri giorni, del resto, sta lasciando
evolvere la questione della complessità su
un
piano che solo apparentemente rompe con
la tradizione, ma che in realtà recupera il senso dell'eredità
greca, del
pensiero dinamico
dei primi atomisti, molto più vicini alla meccanica quantistica e alla termodinamica di
quanto non siano
state le categorie di Aristotele e i miti demiurgici di
Platone.
E
di questo
dinamismo che approfitta per dare
un contesto nuovo alle domande circa l'evoluzione
dell'universo, degli esseri viventi, dei
sistemi sociali. Arriva quindi dal passato, un passato per troppo tempo
dimenticato, il cuore teorico di
queste nuove sfide che la natura lancia alla scienza.
Tutto questo implica un notevole spostamento di prospettiva: si mostra
anzitutto come ogni idea di
esattezza
nella scienza, se e scaturita da
una concezione del Mondo come meccanismo semplice, sia fittizia. Di
conseguenza, si è manifestato
il carattere puramente descrittivo delle leggi scientifiche, la loro incapacità, cioè, di
andare oltre la
semplice supposizione di uno stato di cose, di spiegare davvero un fenomeno, fatto questo che
mette sotto
una luce diversa anche il concetto di osservazione e di esperimento, nonché quello di verità.
L'assenza di regole non deve essere
interpretata come
assenza
di impostazione, ma come la consapevolezza che certi fenomeni con gli stessi
presupposti di
base, si possono manifestare in infiniti
modi differenti. Il caso è da intendere come una nuova
dimensione concettuale che lascia spazio
all'imprevisto, all'evento inaspettato. La casualità deve,
però, essere messa in condizione di
lavorare in modo costruttivo e non degenerare da variabile applicativa in una
variabile di attrito,
con effetti distruttivi e nocivi.
In questo modo il caos è concepito come principio di
indeterminismo, che
nella scienza antica, non è
mai stato
preso in considerazione, se non come antitesi al determiniso o
causalismo: la concezione per
cui in natura nulla
avviene a caso ma tutto
accade secondo ragione e necessità.
Per causa si intende, in generale, ciò da cui dipende un determinato
effetto; di conseguenza la
mentalità
causalistica e deterministica ha
rappresentato uno degli ingredienti fondamentali della scienza, che è nata
proprio
originariamente in seno alla filosofia (fisica) aristotelica e si è sviluppata
proprio in virtù del desiderio di trovare
le cause delle cose e delle leggi che le determinano.
E'
deterministica quella concezione della
natura che esclude qualsiasi forma di casualità nelle cose e
ammette solo l'esistenza di leggi fisiche
che agiscono secondo la più rigida e necessaria determinazione e alla quale sono
conformate
tutte le interazioni causali (cioè i rapporti tra una causa e il suo effetto). Dunque, per tutto ciò che
accade possiamo trovare una spiegazione nelle
cause che hanno concorso a
determinare l'evento,
riconducendocela alla
catena delle relazioni causa-effetto che non ha mai
interruzioni.
In contrapposizione col determinismo chiamiamo
indeterminismo
quella concezione della natura che ammette l'esistenza in natura di eventi che
non sono stati determinati da cause precedenti. Il
clinamen di
Epicuro, che ammette una certa
libertà nell'agire della natura, è quindi un elemento
indeterministico, che
spezza la catena
delle relazioni causa-effetto, dal momento che il movimento eterno del mondo è regolato in
parte da
cause rigorosamente deterministiche, dovute al carattere
proprio della materia e del vuoto, e in
parte è il frutto del caso, cioè del movimento indeterministico, imprevedibile, degli
atomi.
I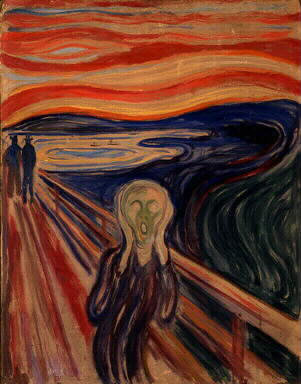 n antitesi, secondo i deterministi (ad esempio gli Stoici, contemporanei
di Epicuro), se conoscessimo
tutte le
cause precedenti a ciascun
fenomeno naturale, saremmo in grado di prevedere anche il più
piccolo movimento
di una foglia e determinare quando e come sboccerà
ciascun fiore della Terra, ma
siccome nella natura è
presente un
imponderabile elemento di casualità, quella foglia e quel fiore
potrebbero sorprenderci con eventi
imprevisti.
n antitesi, secondo i deterministi (ad esempio gli Stoici, contemporanei
di Epicuro), se conoscessimo
tutte le
cause precedenti a ciascun
fenomeno naturale, saremmo in grado di prevedere anche il più
piccolo movimento
di una foglia e determinare quando e come sboccerà
ciascun fiore della Terra, ma
siccome nella natura è
presente un
imponderabile elemento di casualità, quella foglia e quel fiore
potrebbero sorprenderci con eventi
imprevisti.
Se le leggi non ci dicono nulla di preciso e affidabile riguardo il
verificarsi di un fenomeno nello spazio e nel
tempo, se sono ormai soltanto la
descrizione di una possibilità che le cose accadano, allora la scienza si riduce ad
essere solo uno dei
possibili discorsi sul mondo non più l'unico esatto, e le sue regole appaiono sempre più simili a
regole di un
gioco. Del resto, l'osservazione di un fenomeno non è più il
punto di partenza per individuare una
spiegazione; compiere un esperimento non è più un atto costitutivo della conoscenza, ma piuttosto
una pratica esplorativa, un modo come un altro per conoscere. Siamo passati cosi da
un'immagine della scienza come episthmh,
cioè sicurezza, certezza, raggiungimento della verità, alla scienza
come doxa, sapere
fallibile, ipotetico, opinione, un discorso
intorno alle cose.
Forse è questo
l'aspetto più importante di quella crisi che abbiamo individuato come
caratteristica fondamentale della scienza
del 1900, e come fondamento basilare di questo breve studio sulla complessità.
 TORNA
AL SOMMARIO
TORNA
AL SOMMARIO
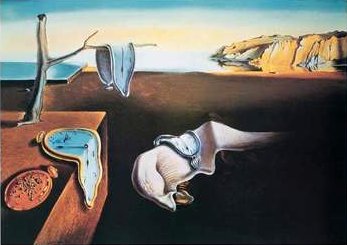
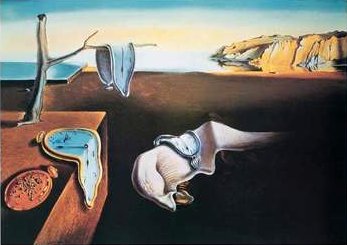
 E inoltre: la messa in evidenza, all'interno di questo fenomeno,
osservato nel suo sviluppo, di alcune
E inoltre: la messa in evidenza, all'interno di questo fenomeno,
osservato nel suo sviluppo, di alcune
Nella scienza non esistono oggetti semplici, cioè la ricostruzione di
un evento osservato sembra
La previsione dello stato futuro di un sistema può sembrare
possibile, ma a costo di ridurre
Le qualità
riscontrate in un oggetto studiato non sono proprie di quell’oggetto, ma sono
la risposta
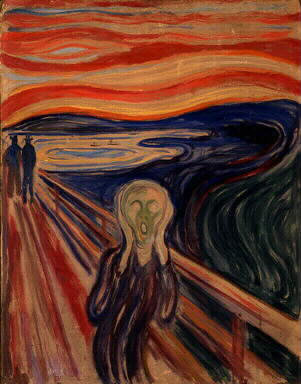 n antitesi, secondo i deterministi (ad esempio gli Stoici, contemporanei
di Epicuro), se conoscessimo
n antitesi, secondo i deterministi (ad esempio gli Stoici, contemporanei
di Epicuro), se conoscessimo